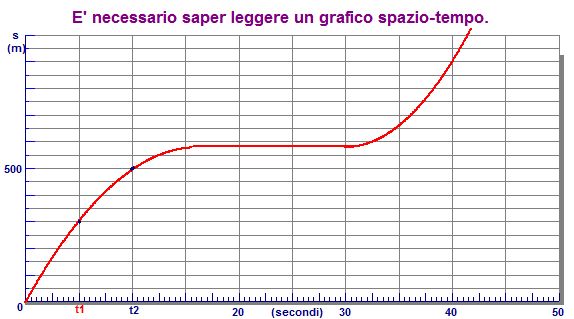PROPAGAZIONE
DEGLI ERRORI NELLE
MISURE INDIRETTE DI
DUE O PIU’
GRANDEZZE FISICHE
1 Una misura di lunghezza
è stata scritta
nella forma : L = (24,5
± 0,2) cm.
2 Quali sono i valori massimo e minimo fra i quali è
compresa?
3 Quanto vale il valore massimo? (24,7)
4 Quanto vale il valore minimo? (24,3)
S
S Potrai capire facilmente che
l'errore assoluto
(dL) di più misure ripetute di una stessa grandezza può essere calcolato con l'importante formula :
dL = [ L(max) - L(min)
] /
2
Infatti
: (24,7 – 24,3) / 2 = 0,2
Vogliamo ora dimostrare che l'errore
assoluto della somma o della differenza di due o più
grandezze fisiche (omogenee
ovviamente) è uguale alla
somma dei loro errori assoluti.
Se ad es. sono date le due misure : L1
= (32 ± 2) cm , L2 = (12 ± 3) cm,
basta capire che
una differenza fra
due valori è massima, se il primo termine (L1) è massimo
ed il secondo
(L2)
è minimo. Infatti : D(max) = 34 -
9 = 25 (cm) e D (min) = 15 cm ,
e l'errore assoluto
della differenza :
[D (max) - D (min) ] / 2 = (25 - 15) / 2 = 5 cm
Non bisogna pensare che se i due errori
assoluti sono uguali, quello della loro differenza sia
zero, perché in realtà è doppio.
Non si può escludere che il risultato
di una misura possa avere errore zero, ma non possia-
mo saperlo e con gli errori si ha il dovere
di essere pessimisti (mai troppo ottimisti).
Rimane allo studente
da dimostrare che anche l'errore assoluto
della somma è
anch’esso
uguale alla somma degli errori assoluti
delle due (o più) grandezze.
oooooo
MISURE INDIRETTE DEL PRODOTTO
E DEL QUOZIENTE DI DUE GRANDEZZE FISICHE.
Vogliamo dimostrare che per il
prodotto P = A*B o per il quoziente Q
= A / B si sommano
gli errori relativi, (non quelli assoluti) .
dA
e dB sono gli errori assoluti su A e B.
Dimostreremo però solo il caso del prodotto
:
Cominciamo col ricordare che : 3) dP = (Pmax - Pmin) / 2
Il prodotto è massimo o minimo se A
e B sono entrambi massimi o minimi, quindi :
4) Pmax
= Amax* Bmax = (A +
dA) * (B + dB) = A*B + A*dB + B*dA
+ dA*dB =
=
(approssimativamente) = A*B + A*dB + B*dA
perché il prodotto (dA*dB)
normalmente è molto minore degli
altri termini. (Già dA e
dB
normalmente sono molto più piccoli di A e B)
.
Analogamente, si ha :
5)
Pmin = (Amin * Bmin) = (A -
dA) * (B - dB) = A * B
- A * dB - B * dA
Sostituendo
4) e 5) nella
3) , si ha
: 6) dP =
A*dB + B*dA. quindi :
 C.V.D.
C.V.D.
Non dovrebbe essere difficile ricordare a
memoria la formula 6), che darebbe
direttamente
l'errore assoluto del prodotto di due
grandezze, ma nel caso che queste siano più di due, la
formula dell'errore assoluto sarebbe più
complicata. Per questa ragione useremo la 1).
Se dP / P = k , l'errore assoluto su
P sarà dato da : dP = k * P.
ooooooooooo
Misura dell’area di un rettangolo e calcolo
dell’errore assoluto
Non volendo lasciare più di una cifra
significativa sull’errore assoluto,
ci conviene trasformare l’area in cm2 dividendo per 100 sia l’area che
il suo errore assoluto.
Quindi l’area del nostro rettangolo è
uguale a :
(2) S =
(102,31 ± 0.35) cm2 = (102,3 ± 0.4) cm2
Come abbiamo detto, sull'errore assoluto non si tollera più di una cifra significativa, per cui, in questi casi :
se dS < 1 si lascia un solo decimale
se invece 1 < dS < 10 nessun decimale
e se dS > 10 trasformiamo in cm2
ooooooo
MISURIAMO IL
VOLUME DI UN
CILINDRO DANDONE L’ERRORE
ASSOLUTO
Se r = 600 (mm) ± 5 (mm) ed h =
500 (mm) ± 5 (mm)
risulta : V = (565486200 ± 13,33) (mm3)
Normalmente sull’errore
assoluto non si tollera più di una cifra significativa, per cui ci conviene
trasformare il valore del volume e del suo errore assoluto in cm3.
Se dV < 1 si lascia un solo decimale
Se 1 < dV < 10 nessun decimale
Se dV > 10 trasformiamo in cm3
Nel nostro caso,
scriveremo il risultato come segue :
V = (565486,20
± 0.01) (cm3)